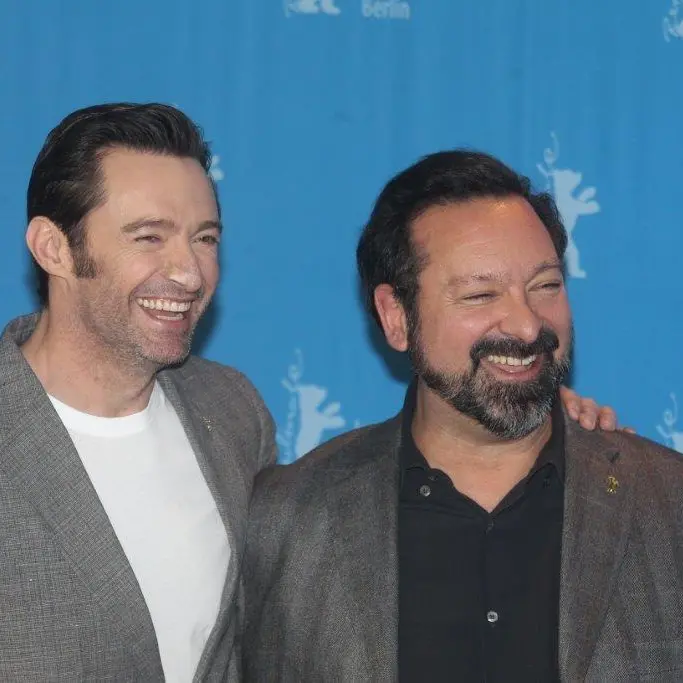PHOTO
Gene Kelly in Un americano a Parigi
Scrive il mai troppo rimpianto Franco La Polla che, quando appare sullo schermo, Gene Kelly – morto trent’anni fa, il 2 febbraio del 1996 – “sprizza energia da tutti i pori, a un punto tale che se da un lato le sue partner non possono che soffrirne, […] dall’altro egli riesce di norma a comunicare vitalità all’ambiente nel quale piroetta e balza come soltanto lui sa fare”. Un maschio performativo, diremmo oggi; forse meno di Fred Astaire, il simbolo del musical precedente a quello di Kelly: leggero e leggiadro, capace far apparire le partner ancor più brave di quanto non fossero, Fred Astaire danza con l’eleganza di chi sembra atterrare dal paradiso (e forse è vero: Cheek to Cheek, “Heaven, I’m in heaven”).
Di Gene Kelly, invece, si percepiscono la disciplina dell’allenamento, la fatica dell’impresa, l’eccezionalità del movimento, con il sorriso nell’affanno che suggella ogni numero e le gocce di sudore che sfondano lo schermo come proiettili. Incarnazione del concetto di “mens sana in corpore sano” (d’altronde è morto a 83 anni), Kelly, figlio di immigrati irlandesi che studia danza dall’infanzia, è il ragazzo che ce l’ha fatta, un ginnasta olimpionico al servizio dell’arte, l’uomo fiero e rassicurante a cui affidarsi per vivere un’avventura, il prodotto di un massacrante esercizio atletico.


Gene Kelly e Frank Sinatra in Due marinai e una ragazza
Se Astaire svolazza tra le nuvole del cielo o gli specchi di una sala da ballo, Kelly appartiene al pianeta Terra. Perciò in tutto il suo cinema (migliore) finisce sempre per piombare in altri mondi: più che una fuga nella fantasia, a spingerlo lontano dalla banalità quotidiana e dalle convenzioni sociali è il desiderio titanico di misurare se stesso al di là del realismo. Lo capisce Vincente Minnelli che lo fa viaggiare nello spazio e nel tempo: dall’artista che approda nei Caraibi ne Il pirata (1948) al pittore innamorato di Un americano a Parigi (1951) fino al turista a Brigadoon (1954), paese che compare ogni cento anni. Opera essenziale, quest’ultima, decisiva e definitiva nell’operazione di svelamento della grande illusione (“Be a Clown” canta nel Pirata): che la verità è un’illusione, la fantasia si rivela nell’inganno e la fine è vicina.
Una consapevolezza già dominante nel grande capolavoro Cantando sotto la pioggia (1952), una celebrazione dell’ideologia dell’intrattenimento americano, una parata nostalgica dove il concetto del riciclo (tutte le canzoni arrivano dal repertorio MGM) si esalta nel conflitto tra cultura alta e cultura bassa, al crocevia di un momento fatale come quello del passaggio da muto e sonoro. Kelly, autore di se stesso la cui fama imperitura resta legata soprattutto a questo film-mito, lo dirige insieme a Stanley Donen, il maestro di un’idea di cinema – e dunque di mondo – in cui c’è assoluta continuità tra realtà e finzione, in nome di quella filosofia della falsificazione secondo cui l’unica verità possibile sta dentro l’atto della performance.


Cantando sotto la pioggia (credits Annex)
Con Minnelli, Kelly esplora l’altrove; con Donen, resta tra noi a dirci che dobbiamo continuare a cantare e ballare anche con lo sconforto nel cuore. E i sei anni che intercorrono tra Un giorno a New York (1949) e il suo cripto-sequel È sempre bel tempo (1955) sembrano molti di più: la fiducia vitalistica si è trasformata in una cinica malinconia, la gioia muscolare della sua imperfezione si è venata di una preoccupazione che appesantisce ogni gesto. E allora tanto vale mettersi in proprio, tacere e fuggire danzando nel Trittico d’amore (1956) e nelle commedie senza impegno a disagio in un mondo che sembra sempre frenarsi sul punto di ballare e cantare (ne gira sei fino al 1970, da Il tunnel dell’amore a Una guida per l’uomo sposato fino a Non stuzzicate i cowboys che dormono, con l’eccezione del revival Hello, Dolly!, 1969).
A più di cinquant’anni, Jacques Demy lo richiama in servizio per Josephine (ovvero Les Demoiselles de Rochefort, 1967): è il congedo del divo (tralasciamo il discutibile Xanadu, 1980), il migliore possibile perché, in un film che celebra e rivisita l’immaginario e le regole del musical classico, Kelly si muove fuori dal mondo (come con Minnelli) restandovi ancorato (come con Donen: la città portuale esiste ma non è realista e il passato non è mai una terra straniera).


Gene Kelly in Un americano a Parigi
(Webphoto)Ovviamente Kelly non lascia eredi, ma la sua lezione riemerge sempre: Hugh Jackman che non vede l’ora di citarlo ogni volta che ha l’occasione di cantare e ballare, Channing Tatum vestito da marinaio in Ave, Cesare! (come Un giorno a New York), Jean Dujardin che sorride ammiccante in The Artist (l’arrivo del sonoro rievocato da Cantando sotto la pioggia), Ryan Gosling che accompagna Emma Stone nell’indimenticabile finale “what if” di La La Land (e stiamo sempre a Un americano a Parigi).