PHOTO
© 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.
In questi giorni in sala c’è un Presidente della Repubblica che chiede “un ulteriore tempo di riflessione” per dirimere su due richieste di grazia e una legge sull’eutanasia. Nella Los Angeles futura non c’è La grazia, ma Mercy, giudice di intelligenza artificiale di una città dominata dalla delinquenza, che sputa sentenze in novanta minuti. L’accusa è fai da te, la difesa pure, il giudizio inappellabile. Condanna a morte o assoluzione.
A farne le spese, adesso, dopo decine di persone fatte giustiziare, è il detective che l’ha creata: Chris Raven, accusato di omicidio dell’ex moglie. Le prove sono schiaccianti, gli alibi nessuno. La sentenza sembra già scritta. Aggrappandosi alla figlia Britt, che lo ritiene un assassino, e alla collega poliziotta, avrà un’ora e mezza per provare la sua innocenza.
Bekmambetov, traslando in un futuro prossimo scenari attuali, recupera il senso dello spettacolo rocambolesco di Wanted: Scegli il tuo destino per un procedural che cede il passo al thriller a tinte revenge movie fondato sul ribaltamento delle apparenze. Con ritmo sincopato, cornice post-apocalittica, patina melò (l’architrave famigliare della trama), il regista kazako condensa e drammatizza il sentimento dominante (e limitante) sull’intelligenza autogenerativa: in primis fascino misto a spavento per efficienza, sintesi e accuratezza che offre, necessità di difendere, poi, l’umano nel processo decisionale, inevitabile integrazione non manichea tra uomo e automa.
Ne esce fuori un film espositivo, un thriller teso anche se non imprevedibile che, pescando nella rosa di sentimenti tipici del genere – giustizia, vendetta, invidia, senso di colpa –, si preoccupa soprattutto di lucidare il portato morale della sceneggiatura di Marco Van Belle, quanto mai limpido e accessibile, benché sottolineato e appesantito da più didascalismi.
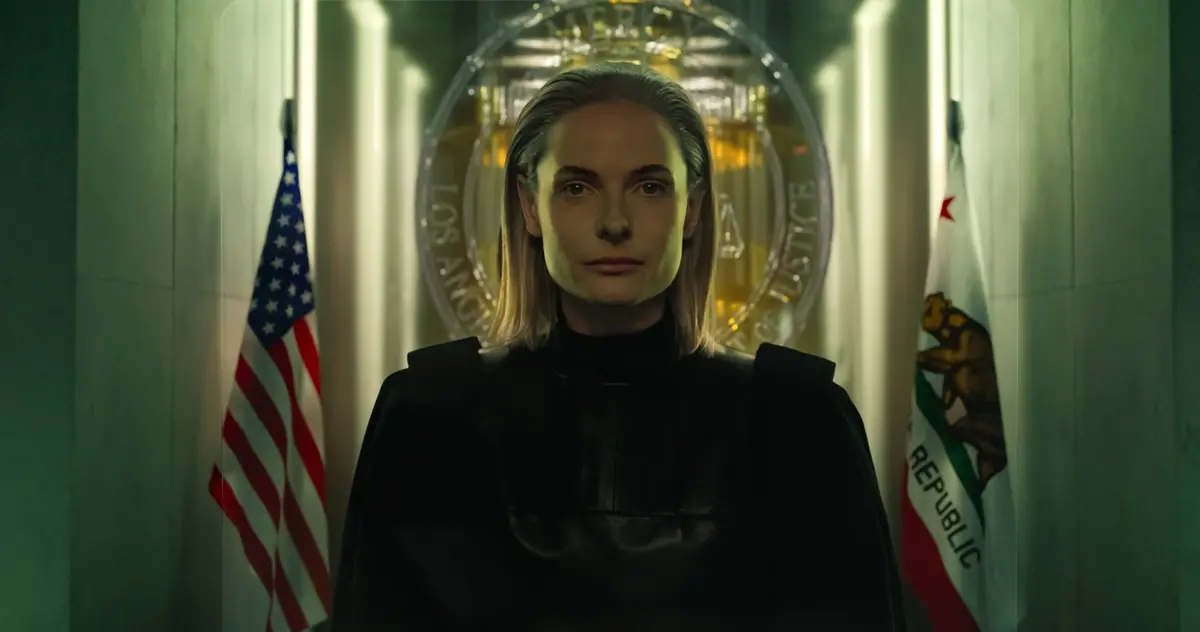
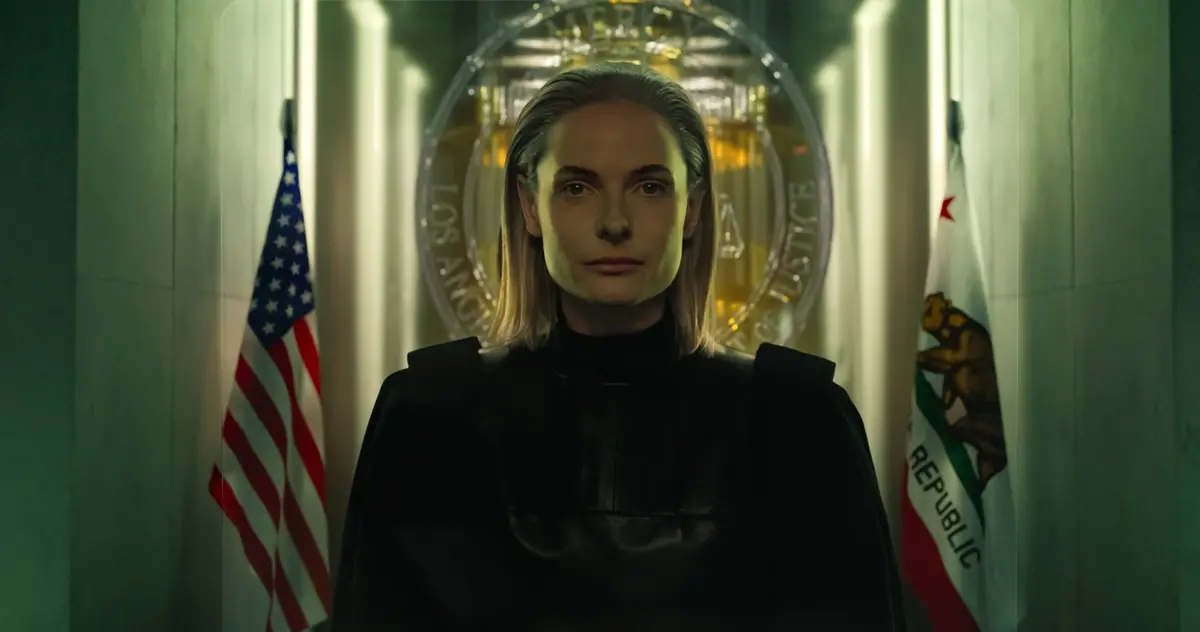
La tesi è che l’intelligenza artificiale – a questo stadio di sviluppo, aggiungiamo noi - è preferibile per efficienza, rapidità e produttività; l’antitesi che non è infallibile né intuitiva come l’essere umano; l’integrazione virtuosa tra uomo e macchina la sintesi.
Mariano De Santis, il temporeggiatore, non sarebbe certo d’accordo con Bekmambetov – “La burocrazia, tutti la detestano perché è lenta ma serve proprio a questo: a non prendere decisioni affrettate”, ma l’Oswaldo Moray tarantiniano (The Hateful Height), sì, quando dice che “è l’essenza di passione, la vera essenza della giustizia”.
Se, infatti, le sentenze lampo al tempo dell’intelligenza artificiale sfollano le aule e snelliscono processi, eliminano i delinquenti, il rischio prospettato dal film è di mandare a morte in un amen persone incolpevoli, sdoganando un giustizialismo spietato che garantisca il controllo sociale preventivo. L’AI non ha pietà, non si contraddice, non crede nel valore riabilitativo del carcere, né nei ragionamenti lenti della burocrazia. All’uomo non resta che opporre “l’intuito ai fatti” in tempi frenetici per correggerla. Pena la morte.
Tra home movies e found footage e split screen ricorrenti, questo film desktop allegorizza pure la nostra condizione sociale di spettatori - incatenati alla sedia mentre ci diluviano addosso sempre più immagini, sempre più svuotate di senso – , ma dietro il contesto malavitoso e l’impianto procedural emerge, in filigrana, un’infausta visione patriarcale della società: la missione riparativa è affidata a un’ispettore formidabile, benché braccato dalle dipendenze (alcool), chiamato ad educare un sistema informatico al femminile (Rebecca Ferguson); a dirigere, pur legato a una sedia, la collega mulatta con scheletri nell’armadio (Kali Reis); a far ricredere la figlia adolescente (Kylie Rogers); a rimpiangere una donna senza individualità, perduta per non averle dato “le giuste attenzioni” (Annabelle Wallis).
Chiudiamo con il rammarico per non poter annotare sulla recitazione del quartetto protagonista, data la versione doppiata del film propinata dalla distribuzione italiana (Eagle Pictures) all’anteprima stampa.
