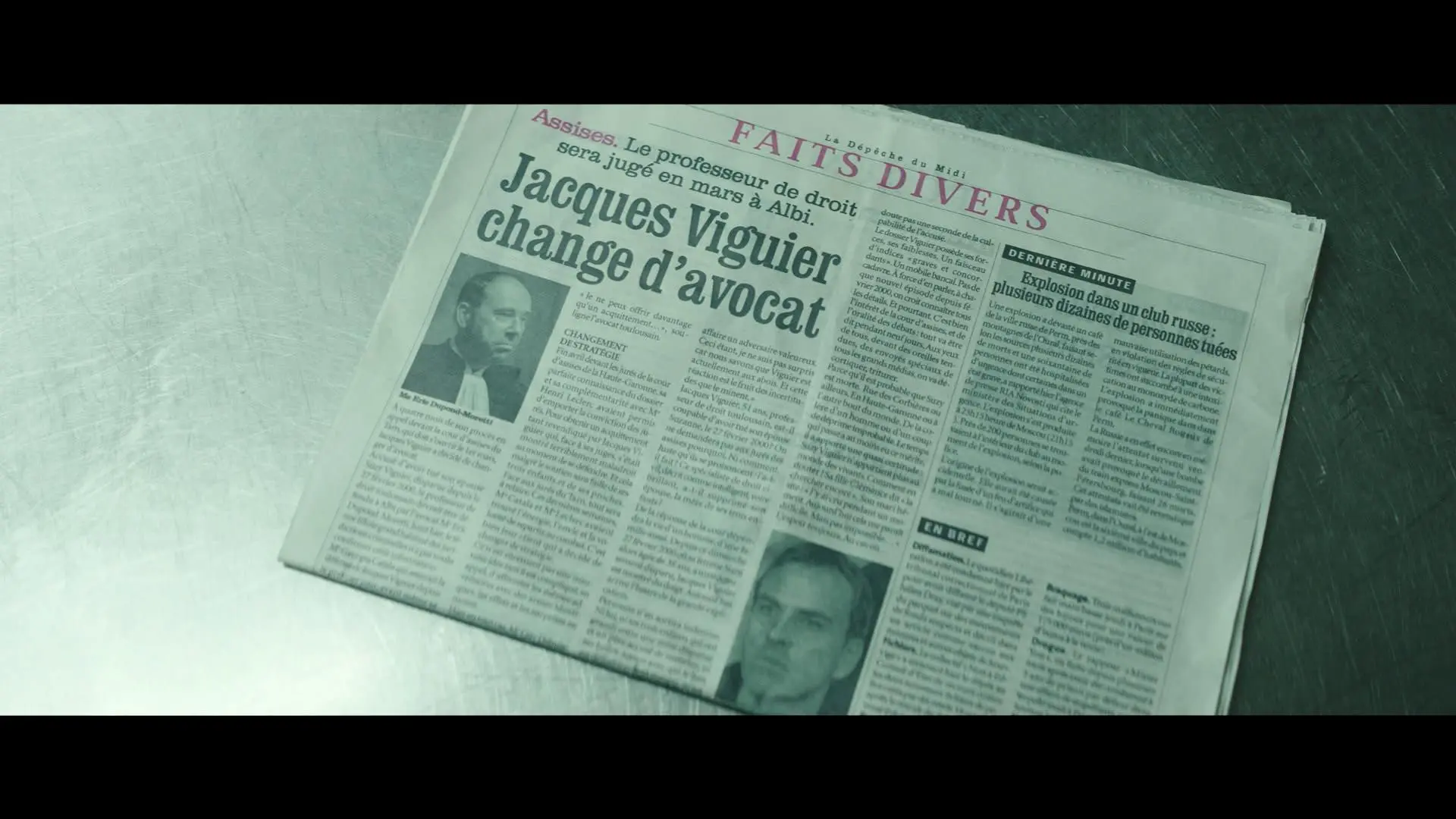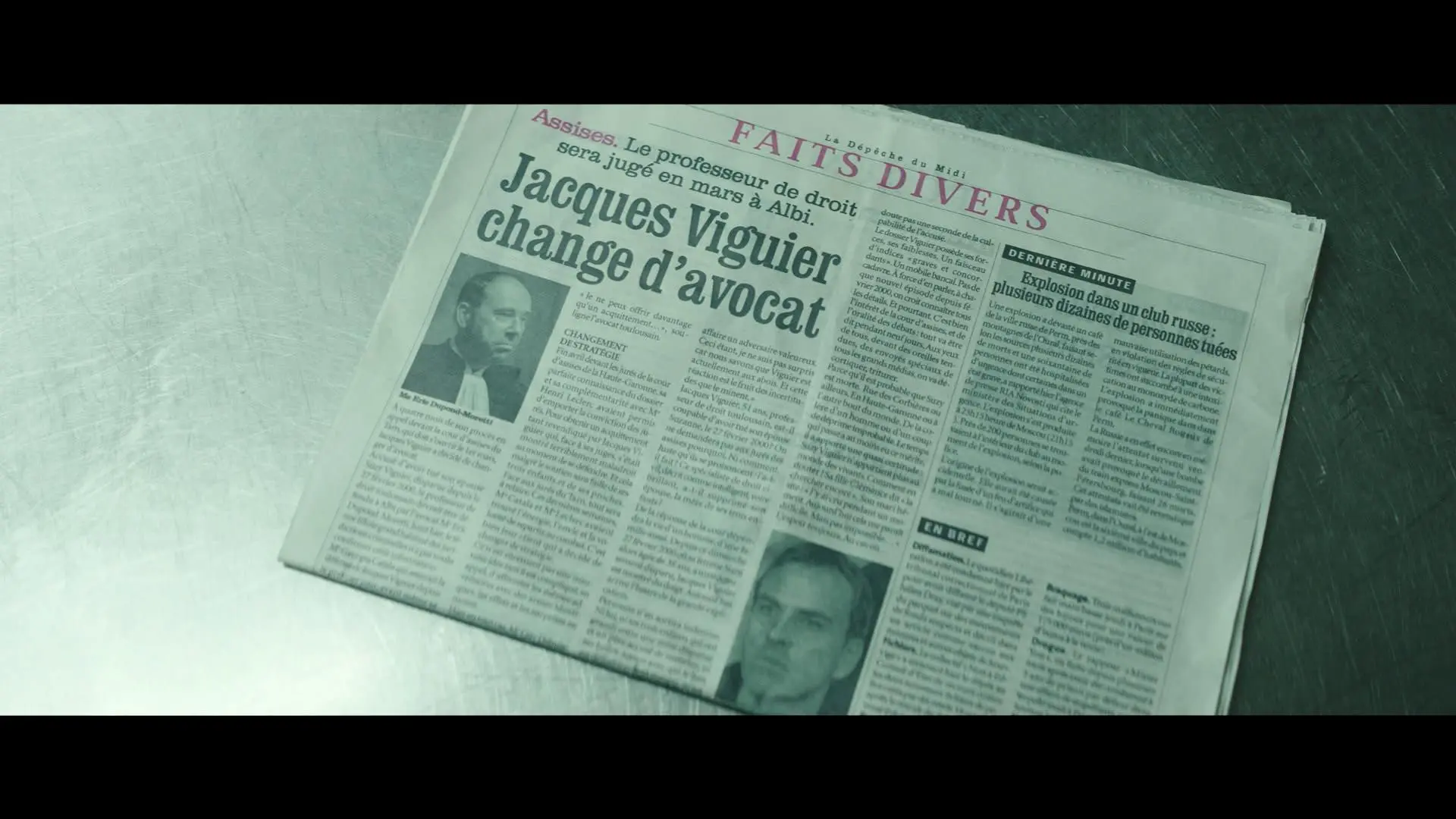PHOTO
Quando – spesso con un provincialismo un tanto al chilo, spesso per sconfortata consapevolezza – diciamo che un certo tipo di film oggi in Italia è impossibile, pensiamo anche a film come Una intima convinzione. Non è un capolavoro, non è nemmeno trascurabile, ma non è questo il punto. Non è la qualità – qui di buon livello, per inciso – a far la differenza, quanto la scelta di un tema che è strutturale e non in funzione della narrazione.
Al centro della storia, infatti, troviamo qualcosa di raro nel nostro cinema: il dubbio. In una società come quella italiana intrappolata nel manicheismo, vittima di assolutismi, di solito allergica alla riflessione anche scomoda, il dubbio pare essere diventato se non una bestemmia quantomeno la testimonianza di un pensiero non all’altezza di quest’epoca di apparenti certezze.
La cosa che rende Una intima convinzione un prodotto oltreché pregevole perfino esotico rispetto ai nostri lidi è la naturalezza con cui prende possesso del genere procedural senza che “il tema” sia unica colonna portante.


In realtà noi avremmo pure una tradizione di “film in tribunale” – usiamo un’espressione meno tecnica – a cui guardare con orgoglio. Parliamo di quei film a cavallo tra contestazione e anni di piombo, con l’aria del tempo contaminata da una paranoia spesso messa in scena attraverso il filtro dell’allegoria, la sfiducia nelle istituzioni e la solitudine del cittadino onesto quali elementi fondamentali di teoremi capaci di farsi intrattenimento. Di fronte a Una intima convinzione viene in mente, per esempio, Il bene e il male di Eriprando Visconti: un esempio per tutti, solo per dire che, sì, noi cose così le sapevamo fare. E bene.
All’opera prima, Antoine Rimbaut dimostra che quello francese, al netto di tutto, è il cinema più disponibile a recepire generi diversi, caratterizzandoli di una cifra che per costituzione francese. Il disegno di personaggi che non sono funzioni ma nervi scoperti, la classe di interpreti eccellenti in grado di restituire titubanze e dolori, un’adesione al contesto sociale che non è pretestuosa ma intimamente connessa alla storia.
La storia è quella del caso Viguier, un fatto di cronaca di vent’anni fa – se ne fa menzione esplicitamente, prendendo le distanze dal period drama – che vide coinvolto Jacques Viguier, un professore di diritto accusato della morte della moglie Suzanne in seguito alle rivelazioni dell’amante della donna. Il corpo non stato mai ritrovato. Grazie all’ostinazione di Nora (Marina Foïs), convinta dell’innocenza dell’uomo, e a un avvocato di grido (Olivier Gourmet), il processo d’appello potrebbe essere l’occasione per ribaltare quella che appare come una verità inattaccabile.