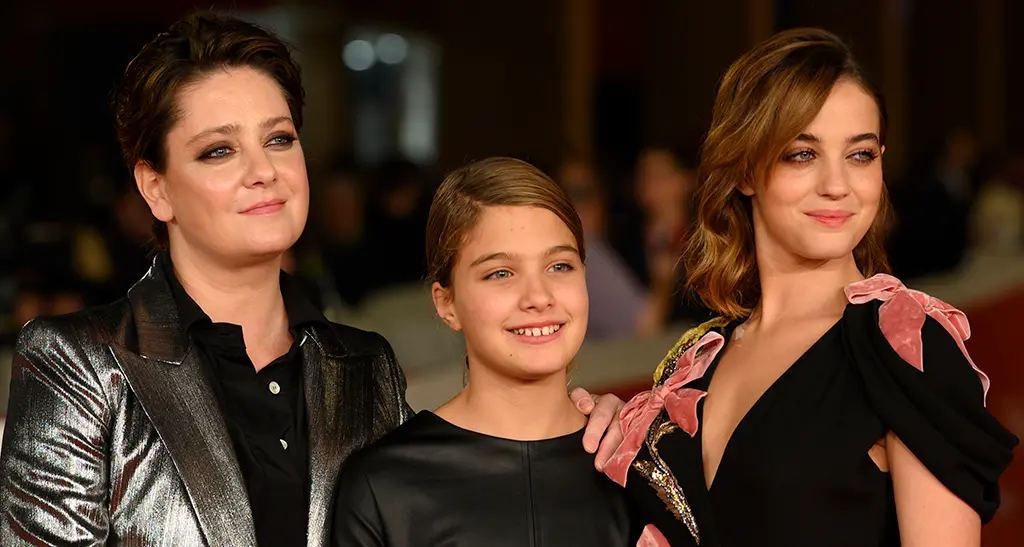PHOTO
Pavarotti
Non stupisce che il meglio di Pavarotti, il documentario che Ron Howard dedica alla figura di Luciano Pavarotti, sia nella musica, nel liberarsi della voce del tenore e della musica sublime a cui diede forza. In realtà non stupisce niente nel film, dall’approccio alle scelte di racconto ed estetiche.
Il film segue la vita, dalla nascita alla morte, del più celebre cantante lirico del dopoguerra attraverso le sue parole, quelle di chi lo ha conosciuto, i brani di repertorio e via biografando. Mark Monroe segue l’abc del documentario biografico scegliendo la via più piatta dal punto di vista creativo, ma anche a suo modo efficace, pensata per un pubblico generico, lo stesso che dagli anni ’80 rese Pavarotti un idolo di massa.
È interessante proprio questo elemento, quello del successo di Pavarotti che Howard segue molto americanamente, in linea con i valori di certo cinema hollywoodiano: l’uomo che con la forza della sua voce ha conquistato il mondo, puntando l’occhio proprio sul concetto di conquista, di globalizzazione in nome dell’arte, mescolando la ricerca della bellezza con il trionfo del mercato. È uno sguardo che di sicuro infastidisce i puristi e i melomani ma che è un modo curioso di guardare al cantante modenese.
Un modo che però non diventa mai la chiave di lettura del film che preferisce invece la via della placida agiografia, in cui i lati “oscuri” sono quelli che si concedono al genio: qualche bizza, qualche scappatella, un velo di scandalo sessuale. Dell’uomo e dell’artista, Pavarotti non dice niente di più di ciò che una qualunque biografia unita ai cliché e al sentito dire non avessero già detto.
Ci si consola con la figura carismatica e con la sua voce, con le immagini dei 3 tenori (la parte migliore del film) e il finale telefonato ma potente, come ogni bis che si rispetti, sul Nessun dorma di Puccini. Con didascalie finali che puntano il dito sui dischi venduti e le opere benefiche. Come un vero uomo americano. Appunto.