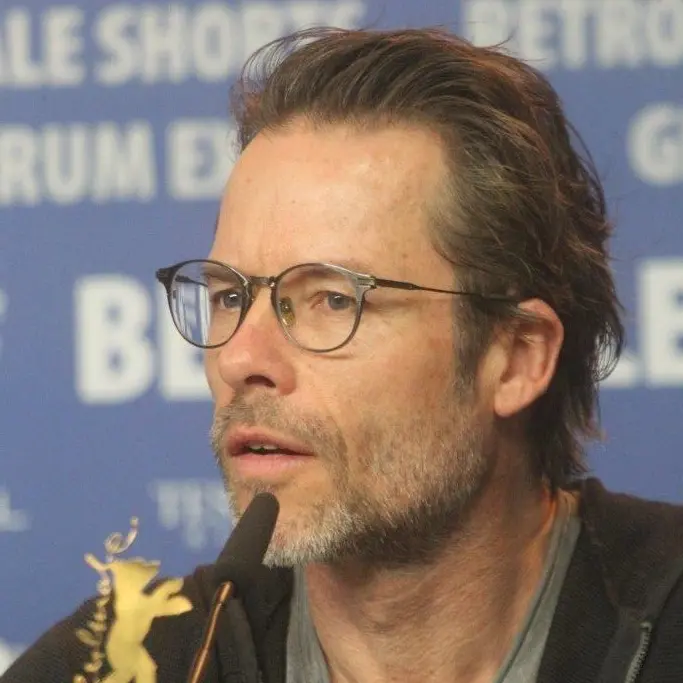PHOTO
Un giovane uomo attraente come Elvis Presley nel western Charro (1969), è immobile in mezzo al deserto con in mano una mitragliatrice ad alta precisione. Non succede nulla, l’uomo non si muove. Intercetta discorsi in arabo. Il giovane, il cui nome è Nero e Jesús, impersonato da un Johnny Ortiz ruvido e sensibile, vuole diventare cittadino degli Stati Uniti, il paese in cui è cresciuto ma che ha dovuto abbandonare quando, con la madre, è stato deportato verso il Sud, in Messico.
L’unico modo legale per tornare nel suo paese, destino che condivide con alcune centinaia di migliaia di ex bambini espulsi durante le grandi retate dei primi anni duemila, è quello di diventare un Green Card Soldier. In pratica, acquisire la cittadinanza provvisoria prestando servizio in corpi speciali dell’esercito americano. Questa legge pensata per aprire possibilità, ma che di fatto permette di distruggere vite a discrezione del datore di lavoro, è solo una delle tante pensate dal governo degli Stati Uniti dopo l’11 settembre, per far fronte alle necessità di una guerra al terrore globale e, di fatto, impraticabile, almeno nei termini ipotizzati dai politici USA 15 anni fa. Le fila di quest’esercito ombra ausiliario sono riempite soprattutto da neri disoccupati, immigrati temporaneamente ex illegali, o dai figli di una classe media lavoratrice che, nell’America di oggi, non può più permettersi un’educazione dignitosa.
La prima parte del film di Rafi Pitts, Soy Nero, in concorso alla Berlinale, racconta i tentativi del giovanotto di attraversare la frontiera del Messico con gli Stati Uniti, e del suo arrivo a Los Angeles. La seconda invece racconta le esperienze di guerra del soldato neo americano. In una scena iniziale è il momento più alto del film. Il ragazzo è ancora in messico, è notte, e il cielo scoppia di fuochi artificiali senza fine, sotto una folla a perdita d’occhio che festeggia qualcosa, o qualcuno. È la festa della gioia dei poveri: a organizzarla è il boss di un cartello messicano della droga. Soy Nero è senza dubbio uno dei contributi più coraggiosi di questa 66ma Berlinale (in concorso). Perché non è facile raccontare un tema di attualità apparentemente così cinematografico, ma che, ad oggi, non lascia trapelare il minimo segnale di come andrà a finire.